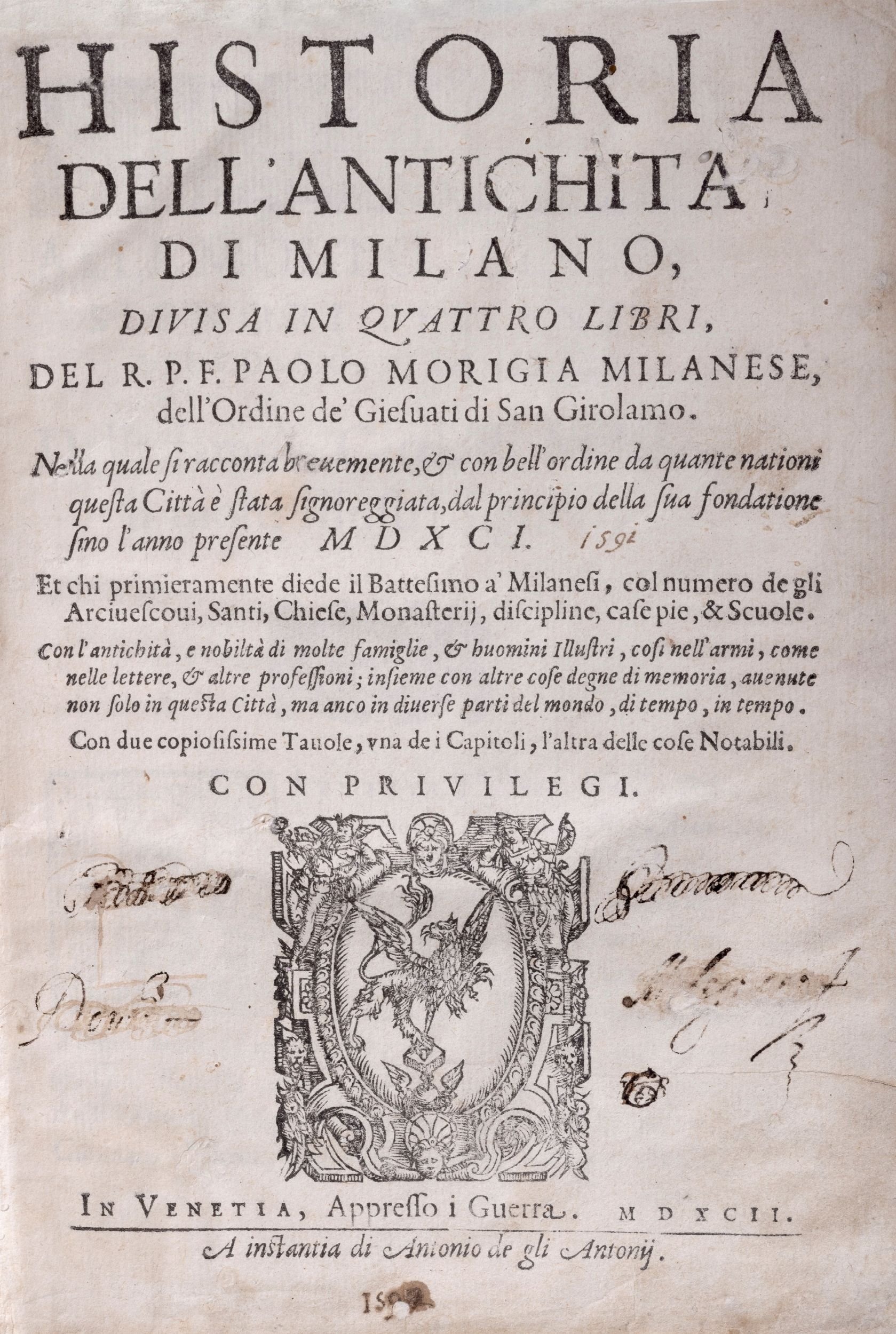Chi Siamo
L’ente privato Antica Consorteria Comitatus Martexana riunisce gli esponenti nobili e notabili di otto antiche famiglie lombarde, al fine di promuoverne la ricerca storica, genealogica ed araldica, salvaguardando così la conservazione della memoria storica e dell’identità dei propri membri. La presenza di un numero elevato di esponenti delle suddette famiglie in contesti storici e geografici eterogenei, congiunta alla rarità di indagini a essi specificamente dedicate, ha contribuito alla costruzione di un panorama storiografico caratterizzato da frammentarietà e dispersione. Parimenti dispersiva e policentrica si caratterizza anche la conservazione delle rispettive fonti primarie. Si promuove pertanto non solo la ricerca storiografica di nuova impostazione, ma anche la ricomposizione e sistematizzazione della produzione esistente in un’ottica unitaria e coerente.
Le otto famiglie originarie sono da intendersi come quelle già attestate in epoca alto-medioevale, verosimilmente legate tra loro da vincoli di sangue, riunite in una struttura consortile e, per la maggior parte, detentrici del dominatus loci sulle rispettive città o luoghi d’origine: i Giussani (Giussano), i Casati (Casatenovo), i Beolchi (Beolco, frazione di Olgiate), i Brenna e i Carugo, signori delle omonime località, gli Incasati (Incasate), i Gironi e gli Squarcia Giussani. A tali famiglie si affiancano membri di stirpi affini o discendenti, quali, a titolo esemplificativo, i Carugati e i Sormani Andreani.
L’insegna dell’Antica Consorteria Comitatus Martexana si ispira ai collari degli ordini cavallereschi ed unisce gli elementi distintivi delle famiglie ch’essa rappresenta: la “trizia de Casate”, simbolo del legame parentale, otto piastre della Corona Ferrea, una per ogni famiglia originaria a memoria dell’origine longobarda, ed il mastio, carica dello stemma condiviso.
La Storia
“De Trizia de Casate.
Isti duo supradicti imperatores Ugo et Lotharius instituerunt in Vigezolo quemdam virum nobilem suum vicarium generalem , cui inerant tres filii . Tunc temporis illi de Ponziis habitabant in Casate veteri , qui totam Marthesanam sua potentia subpeditabant ; contra quos hic vicarius pugnavit , et eos de Marthesana expulit. Tunc unus filius istius vicarii construxit Casate novum ; de isto nati sunt illi de Casate ed de Bebulco. De alio fratre mediocri nati sunt illi de Gluxiano; ideo propter sanguinis affinitatem dicti sunt Trizia de Casate . De alio fratre minore nati sunt illi de Vigezolo.”
In tal guisa si espresse, nei primi anni del XIV secolo, il cappellano di Giovanni Visconti, il frate domenicano Galvano Fiamma, nella cui opera storiografica Chronicon Maius affermò che, passato l’anno 937 d.C., i re d’Italia Ugo di Provenza e suo figlio Lotario II, posero in Vigezolo un nobile personaggio quale loro vicario generale, il quale espulse dalla Martesana i Ponzii abitanti in Casate Vecchio ed ivi fortissimi. Quel vicario ebbe tre figli, dei quali il primo fondò Casate Nuovo e da costui discesero quei di Casate e di Bevulco, dal secondo vennero quei di Giussano che per l’affinità furono detti "Trigia" De Casate, e dal terzo quei di Vighizolo”.[1]
Galvano Fiamma in una miniatura estratta dal Cronica de Antiquitatibus Civitatis Mediolanensis, codice Trv.1438 conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano.
Gli stessi avvenimenti vennero ripresi nel 1503 dallo storico della corte sforzesca Bernardino Corio, nella sua opera Mediolanensis Patria Historia, il quale però li collocò nell’anno 1126 e vide come protagonista non Lotario II re d’Italia, ma l’Imperatore del Sacro Romano Impero Lotario II di Supplimburgo, il quale:
“costituì in Lombardia Apollonio vicario generale, il quale dimorava a Vigevano, e aveva tre figliuoli. In questo tempo quei di Pontij con la sua possanza ministravano tutta Martesana, il perché questo Vicario gli andò contra e al tutto gli estirpò di quella contrada. Onde poi il maggior figliuolo del Vicario Imperiale edificò Casal Nuovo, e da costui discesero quelli da Casate e da Beulco. Del secondo figliuolo quei da Glusiano, onde per l'affinità di sangue sono detti tricia di Casate. Del terzo nacque quei di Vighizoio”.[2]
Quanto tramandato da Galvano Fiamma e da Bernardino Corio potrebbe includere elementi leggendari, ma testimonia, assieme alla comunanza del blasone, che queste famiglie di parte ghibellina, tutte provenienti da borghi limitrofi della Martesana, formarono una consorteria, ossia una stretta alleanza parentale, che mirava a proteggere il prestigio ed i privilegi dei suoi membri, nell’ambito di un periodo storico e di un territorio segnato da frequenti conflitti di carattere sociale, politico, religioso e militare. Tale consorteria, spesso indicata dal nome delle famiglie più prominenti come “consorteria dei Giussano” o “dei Casati”, fu la più potente ed influente consorteria del contado della Martesana[3]. Alle tre famiglie direttamente citate, la famiglia Giussani originaria di Giussano, la famiglia Casati di Casatenovo, e la famiglia Beolchi di Beolco (Olgiate), si unirono, o da esse emersero, anche le famiglie Brenna, Carugo (signori dell’omonimo comune), Incasati (originaria di Incasate), Gironi, e Squarcia Giussani.
In questo periodo storico dell’Italia Settentrionale, l’appartenenza ad una consorteria fu uno degli aspetti distintivi delle stirpi aristocratiche, alle quali ci si riferiva spesso come alla pars dei membri delle consorterie, o “illi de hospicis”[4]. In particolare, nel contesto milanese, gli esponenti delle famiglie aristocratiche venivano comunemente indicati come membri delle “parentelle”[5] o consortes. La consorteria dei Giussani, o Casati, rispecchia quella che fu una comune strategia complementare di “solidarietà tra clan”, adottata a partire dalla fine del X secolo da molte famiglie terriere, le quali, per salvaguardare l'integrità dei propri domini, cominciarono ad imporre misure di consolidamento della crescente agnazione mediante politiche dinastiche e regole di condominio tra famiglie affini e di legame parentale. I patrimoni vennero ripartiti e raggruppati tra i rami dei Domini locali secondo rigorosi principi di trasmissibilità maschile (per le famiglie di legge salica), organizzandoli in nuove signorie castellari, ossia afferenti alla giurisdizione facente capo ad un castello, e adottando cognomi anch’essi castellari e toponomastici[6].
A suggellare l’unione consortile ed il legame parentale, il blasone condiviso:
Arma della famiglia de Carugo.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia Brenna.
Marco Cremosano, Stemmario Cremosano, 1673 - 1704 circa;,
Archivio di Stato di Milano, c. 1673 - 1704. CC BY-NC-SA 4.0
Arma della famiglia de Gironis.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia de Beolcho.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia de Giussano.
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia de Inchaxate (Incasati).
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia de Caxate (ossia Casati).
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Arma della famiglia Di Straci cioè Squarciis de Glussiano (ossia Squarcia Giussani).
Gian Antonio da Tradate, Stemmario Trivulziano,
Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano, c.1465.
copyright © Comune di Milano – tutti i diritti di legge riservati
Circa il legame parentale tra le diverse famiglie della consorteria, dal punto di vista documentario rimangono ad oggi solo alcuni indizi. A partire dai primi decenni del XII secolo cominciarono a manifestarsi delle diversificazioni antroponimiche interne alla parentela delle famiglie aristocratiche. All’antico cognomen toponimico si aggiunse o sostituì il nome proprio o soprannome di un antenato eponimo all’origine del ramo. Il progressivo inurbamento delle antiche famiglie feudali promosse questa nuova modalità di designazione, secondo la quale si preferì sempre più il riferimento ad un antenato che fondò la fortuna dei discendenti e s’impresse nella memoria dei concittadini, per esempio esercitando funzioni pubbliche, piuttosto che quello all’antico dominio rurale, ormai frammentato tra un crescente numero di co-signori[7]. A tale evoluzione antroponimica sembrerebbe ricondursi l’origine della famiglia de Gironis, il cui cognome infatti figura inizialmente come nome proprio, o soprannome, adottato da alcuni membri di un ramo della famiglia Giussani[8]. In due atti del 1254 e del 1274 figura Guglielmo Gironus de Gluxiano[9], mentre Pietro Gironus de Gluxiano fu Console di Giustizia di Milano nel 1275[10], e ancora Martino Gironus de Gluxiano, fu testimone in un atto del 1290[11]. Un percorso simile si attribuisce alla famiglia che lo Stemmario Trivulziano riporta sinteticamente come “Di Straci”, ma che si denomina più precisamente “Squarciis de Glussiano” e che originò anch’essa da un ramo della famiglia Giussani[12].
La formula Gironus de Gluxiano potrebbe altresì indicare proprio l’ammissione dei de Gironis nel consortile dei de Gluxiano. Era uso infatti, soprattutto negli Alberghi dei Nobili genovesi, che le famiglie ammesse aggiungessero al proprio cognome quello della famiglia più potente, e.g. il Serenissimo doge della Repubblica di Genova Luca De Castro venne ammesso all’Albergo dei Grimaldi ed assunse il nome di Luca Grimaldi De Castro, il vescovo Simone Pasqua venne ammesso all’Albergo Di Negro ed assunse perciò il nome di Simone Pasqua Di Negro, etc. Più dibattuto, ma comunque simile, è il caso del cardinale e giurista Comes Glusiano de Casate il quale, nonostante fosse figlio di Giordano de Caxate e quindi appartenente alla famiglia dei Casati, include al proprio nome quello dei Giussano[13]. Infine, il probabile condominio delle diverse località delle famiglie della consorteria, fece sì che la medesima persona fosse menzionata con diversi “cognomi” a seconda del concomitante luogo di residenza. Ne è un caso evidente il fatto che Forzanus de Carugo, figlio di ser Rodolfo de Carugo, presa dimora a Cassate, viene citato in un atto come Forzani de Cassate[14].
Interessante e a suo modo distinto invece il caso della famiglia Beolco. La contessa consorte Ferlinda da Beolco, figlia di Bertarido, signore di Beolco, sposò Attone di Guiberto, membro della dinastia comitale franca dei Corradidi ed ultimo conte di Lecco. Attone di Guiberto fu strenuo sostenitore di Berengario II d'Ivrea, successore al titolo di re d’Italia dello stesso Lotario II che, secondo Galvano Fiamma, avrebbe posto in Lombardia il Vicario Generale dal quale discesero le famiglie della consorteria.
-
[1] Chronicon Extravagans et Chronicon Maius, Galvano Flamma, a cura di Antonio Ceruti, Torino, 1869, p.144.
[2] L’Historia di Milano Volgarmente Scritta dall’Eccellentissimo Oratore M. Bernardino Corio, Invinegia per Giovanni Maria Bonelli, 1554.
[3] Milano in Età Comunale (1183-1276) Istituzioni, Società Economia, Paolo Grillo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2001, pag 284
[4] Un’Oligarchia Urbana Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Alessandro Barbero, Viella, 1995, p.31
[5] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte II: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.689
[6] The Italian City-State from Commune to Signoria, Philip Jones, Clarendon Press Oxford, 1997, p.114; Francois Menant, Le modes de dénomination de l’aristocratie italienne aux XIe et XIIe siècle: premières reflexions à partir d’exemples lombards, Mélanges de l’école francaise de Rome. Moyen-Age, tome 107, n.2, 1995, p.540 e ss.
[7] Francois Menant, Le modes de dénomination de l’aristocratie italienne aux XIe et XIIe siècle: premières reflexions à partir d’exemples lombards, Mélanges de l’école francaise de Rome. Moyen-Age, tome 107, n.2, 1995, p.542 e ss.
[8] Trivellone, Alessia. « Qui a tué Pierre de Vérone ? Conflits et résistance anti-inquisitoriale à Milan au xiiie siècle ». Contester au Moyen Âge : de la désobéissance à la révolte, édité par Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, Éditions de la Sorbonne, 2019, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.55227.
[9] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.117; e Vol II Parte II, p.778
[10] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte II: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.815
[11] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.552
[12] G. Sitoni di Scozia, Theatrum genealogicum Familiarum illustrium Nobilium et Civium Inclitae Urbis Mediolani, famiglia Giussani, 1705; Sito web dell’Archivio di Stato di Milano, visitato il 2025-03-07, https://archiviodistatomilano.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/Patrimonio_archivistico/Soggetti_produttori/Squarcia_Giussani__sec._XIV_-_sec._XVIII_.pdf .
[13] Mather, Richard. “The Codicil of Cardinal Comes of Casate and The Libraries Of Thirteenth-Century Cardinals.” Traditio, Vol. 20, 1964, Pp.319–50. Jstor, Http://Www.Jstor.Org/Stable/27830773; Enciclopedia Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 21, “Conte Casati”, (1978).
[14] Gli Atti del Comune di Milano nel Secolo XIII, Maria Franca Baroni, Roberto Perelli Cippo, Vol II Parte I: 1251-1262, Tipolitografia Ferraris, Alessandria, 1982, p.131
Rassegna Stampa
Estratti e riferimenti editoriali concernenti la Antica Consorteria Comitatus Martexana.
Notiziario Araldico : La ricerca genealogica e la memoria nobiliare nella Martesana
Articolo dedicato alla ricerca genealogica e alla valorizzazione della memoria nobiliare nella Martesana, con particolare riferimento all’attività della Antica Consorteria Comitatus Martexana.